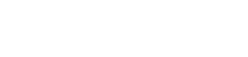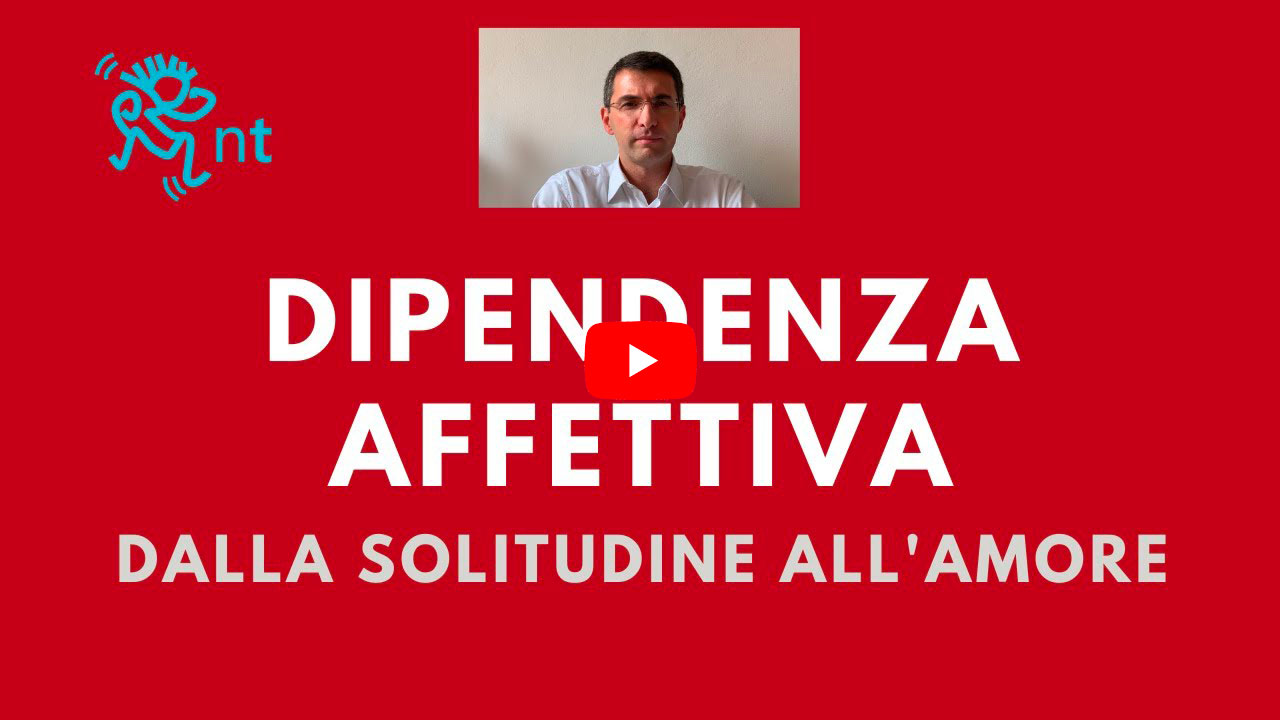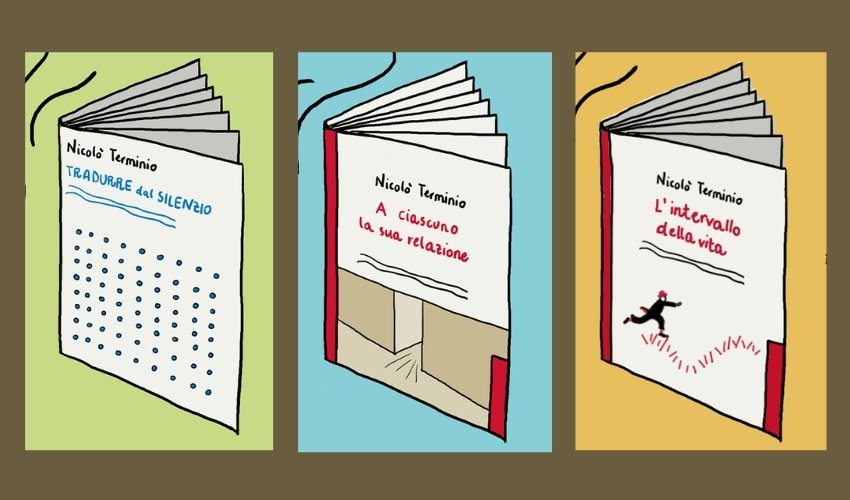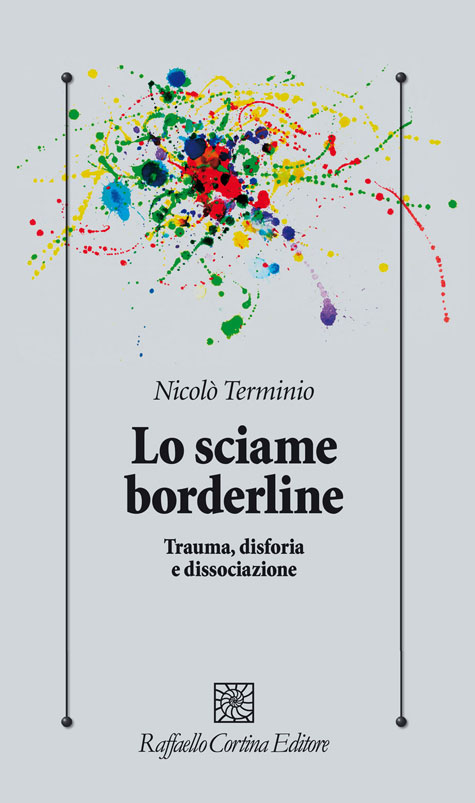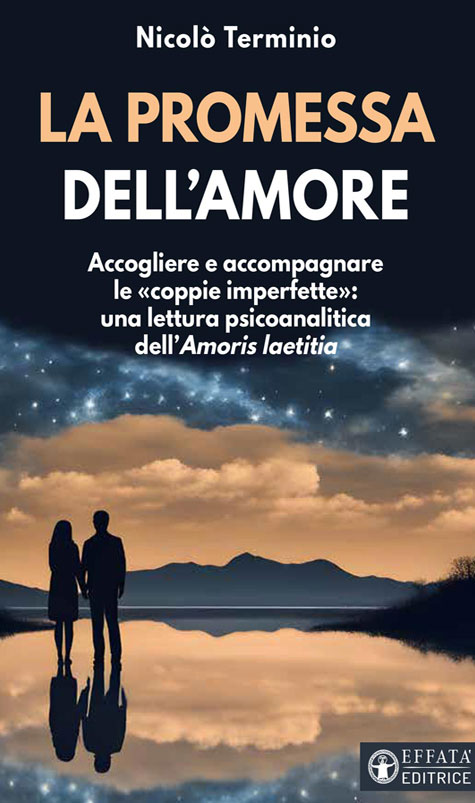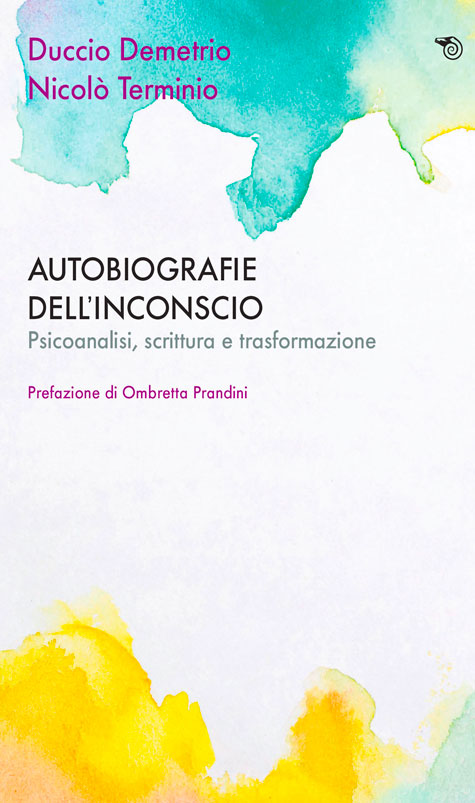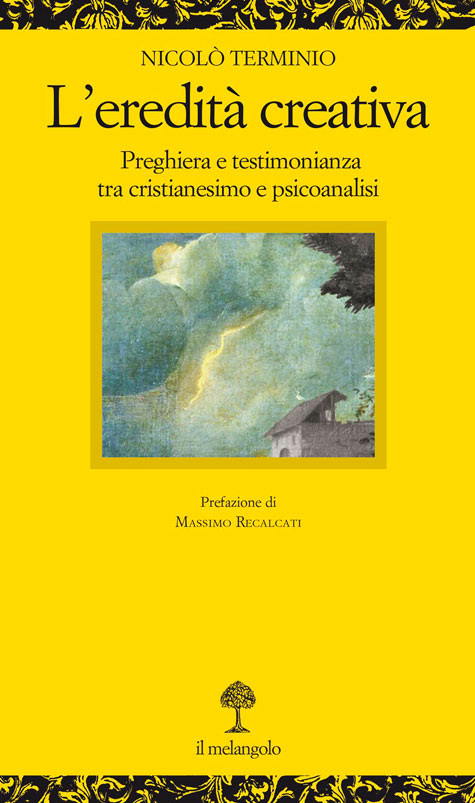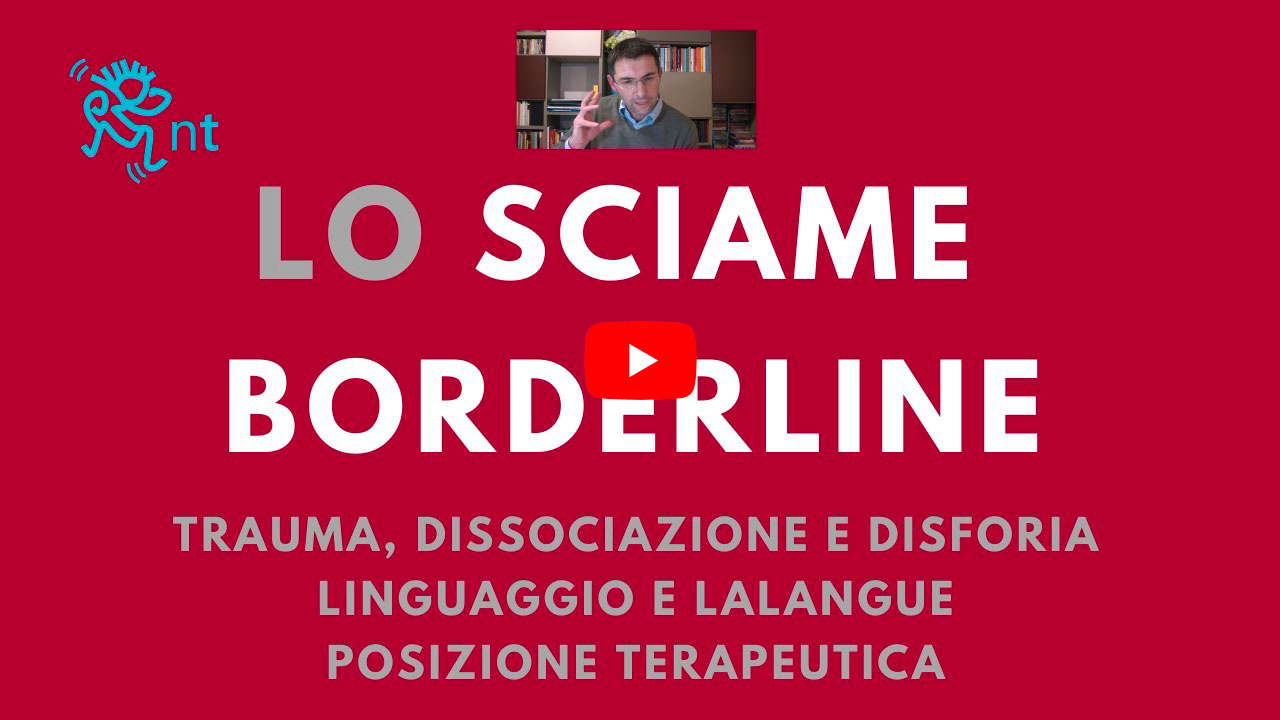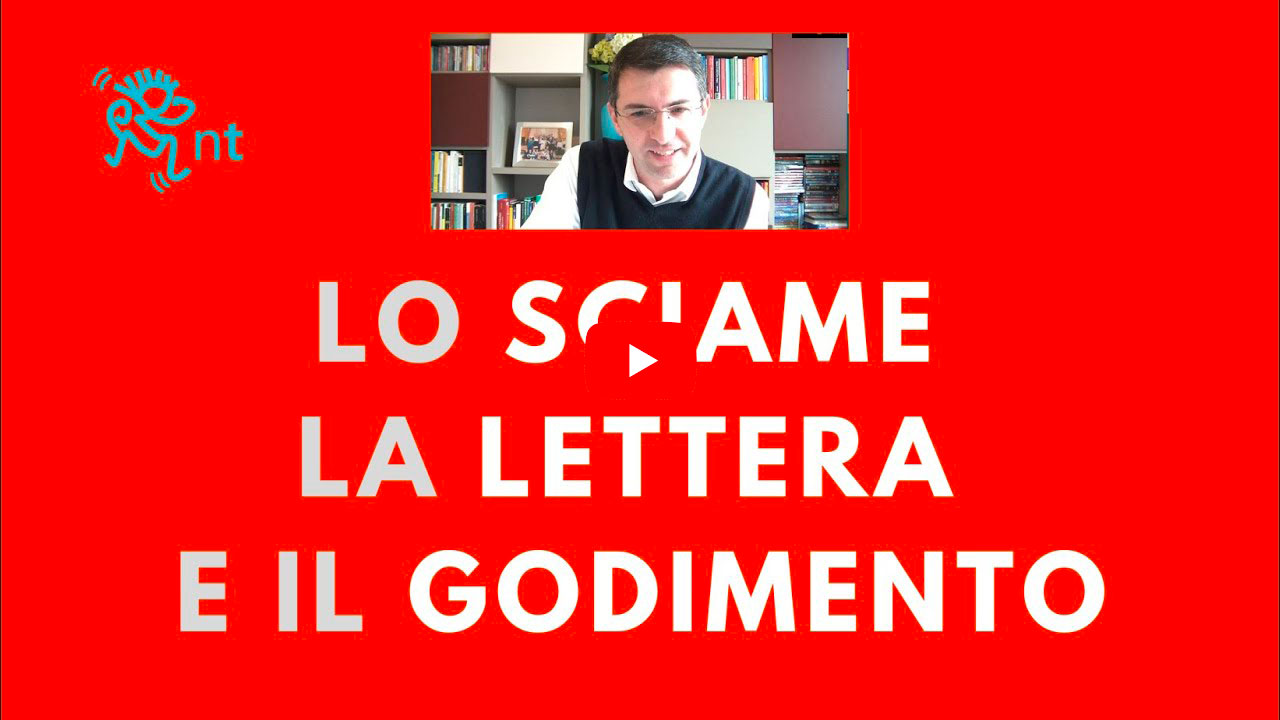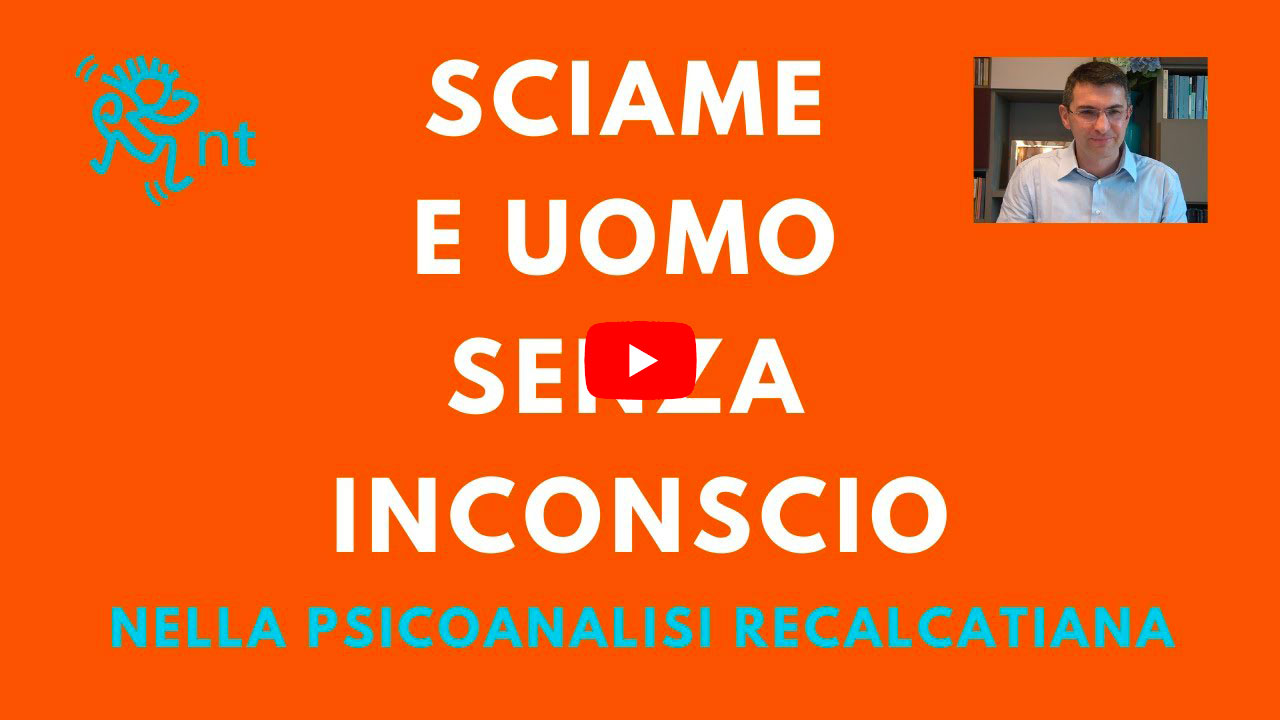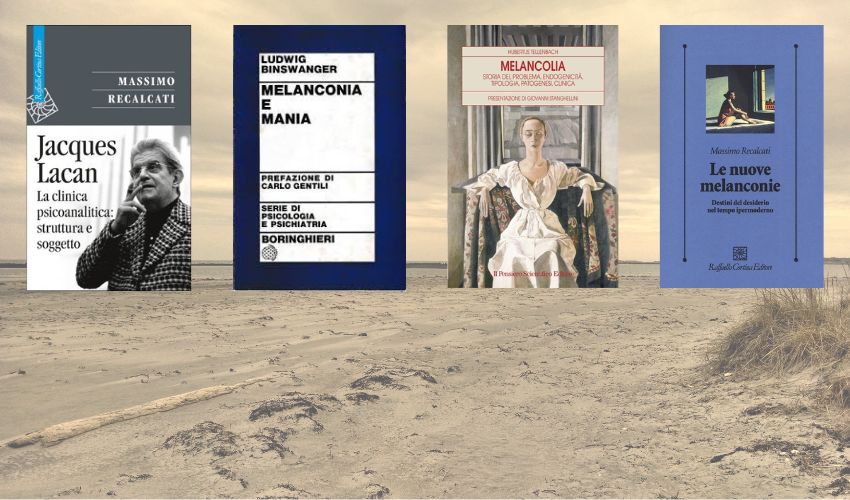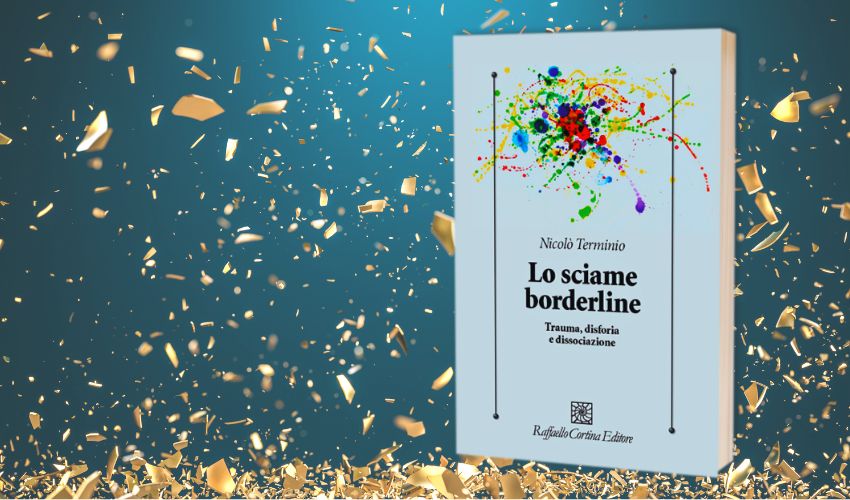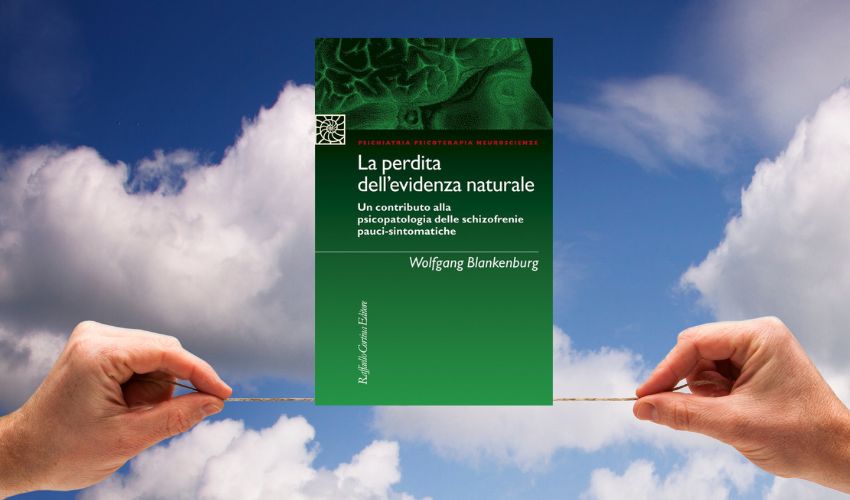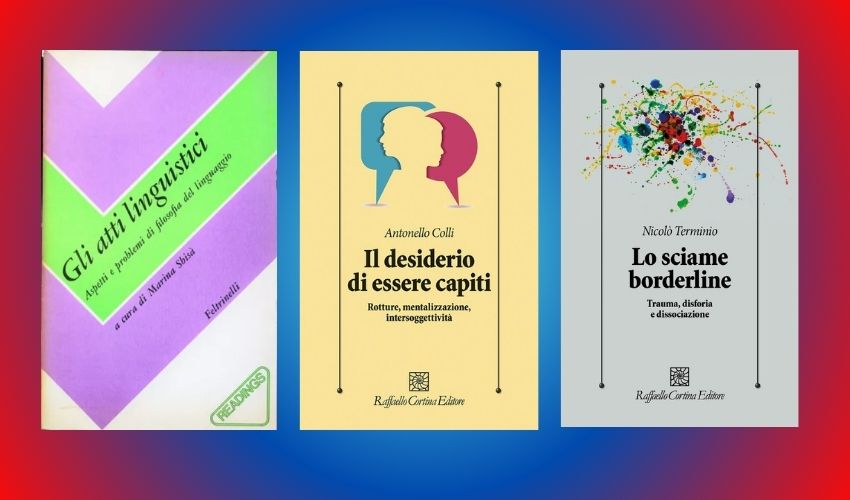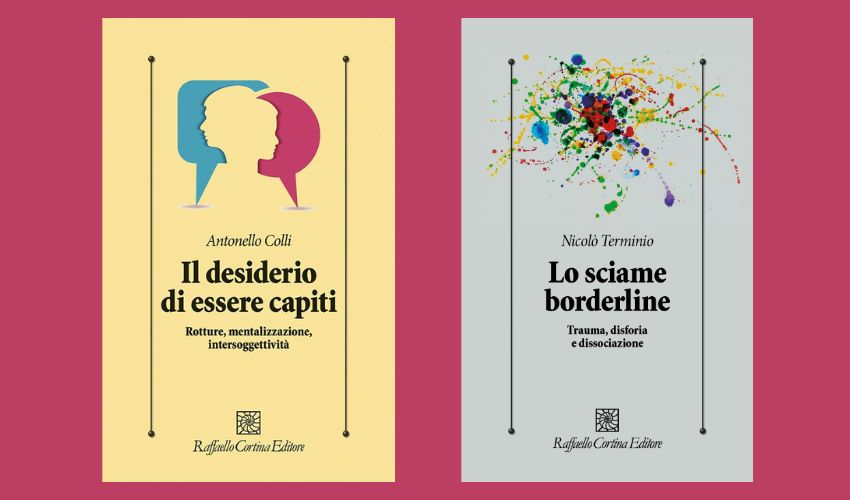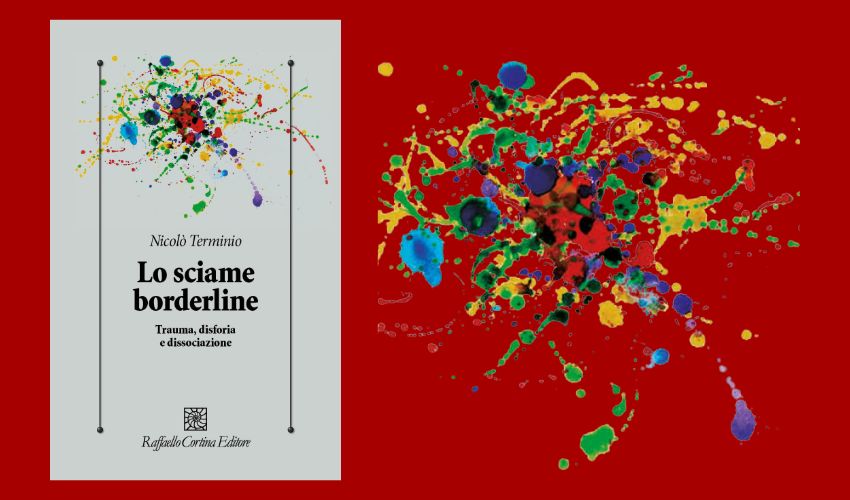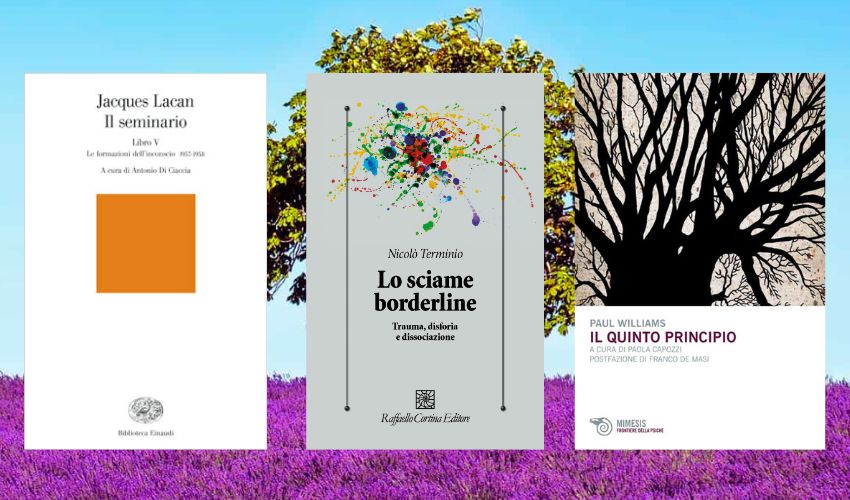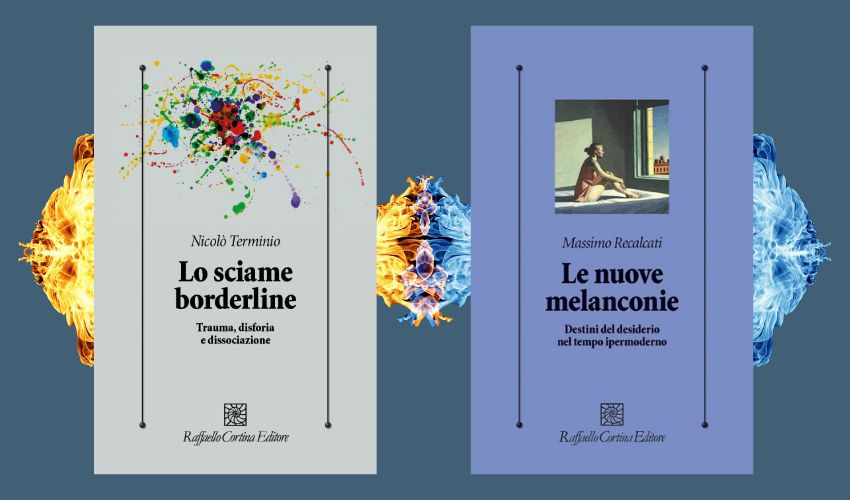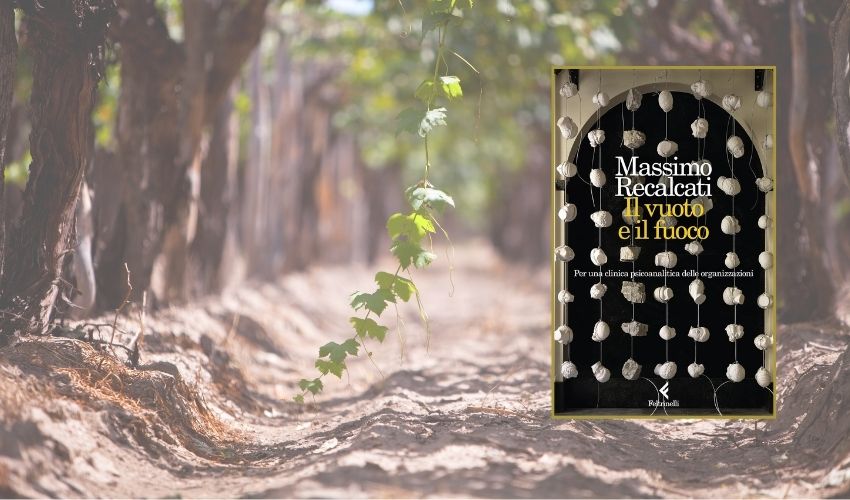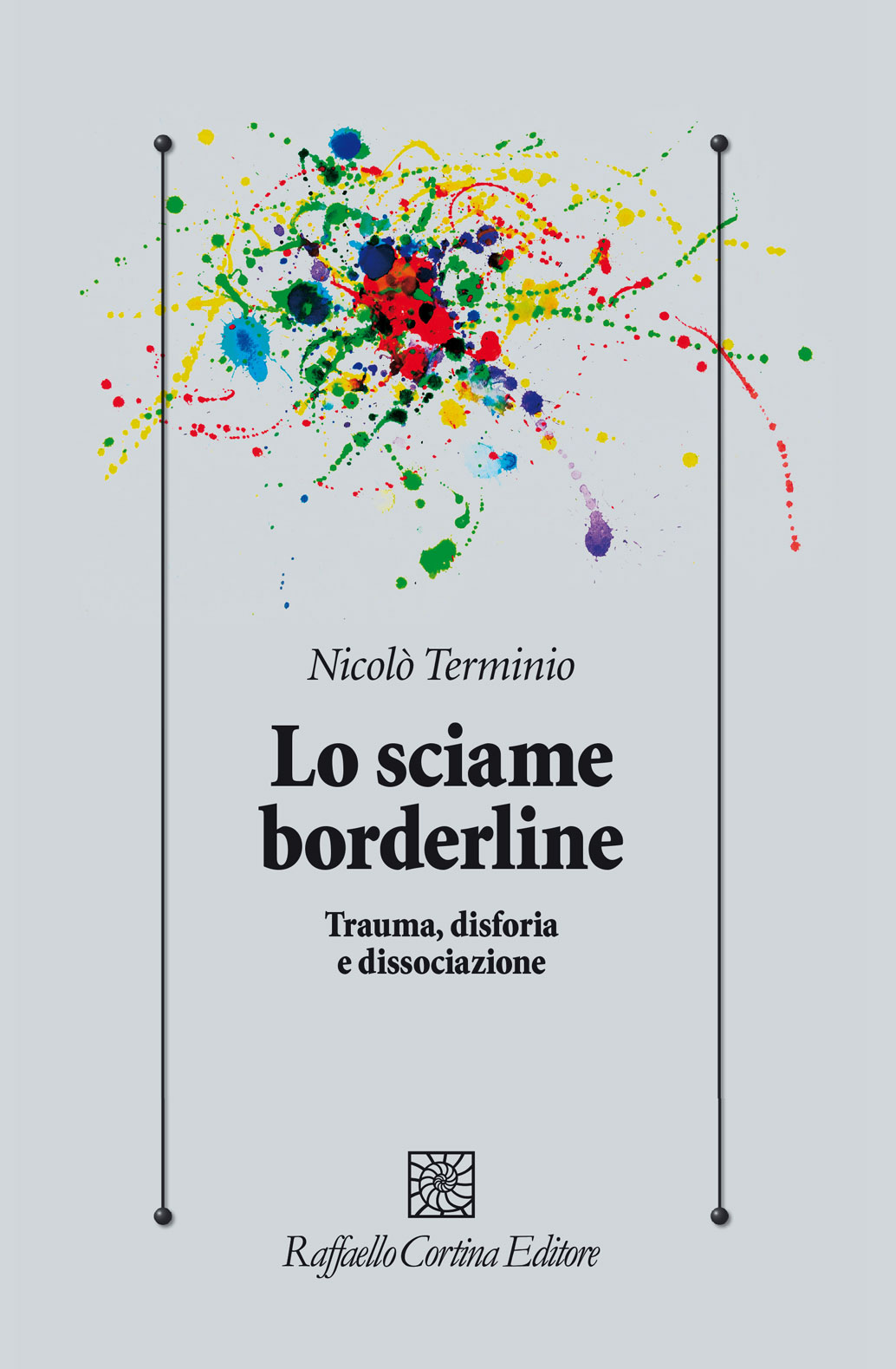Umore, emozioni e affetti
La distinzione tra umore, emozioni e affetti è centrale nel dare un orientamento alla cura. Ci sono infatti emozioni senza Altro ed emozioni con l'Altro, ed è sulla base di questa distinzione che va calibrato l'intervento terapeutico.
L’umore comprende la parte emotiva della nostra esistenza; l’umore entra in risonanza e in dialettica con la dimensione affettiva. L’umore indica uno stato emotivo privo di un "oggetto intenzionale", mentre l’affetto esprime il legame che si istituisce tra le emozioni e un "oggetto intenzionale".
Per oggetto intenzionale intendiamo innanzitutto un altro soggetto. L’umore è allora quella condizione emotiva di base che attende di connettersi con un proprio oggetto intenzionale, in modo che tale oggetto possa svolgere la funzione di oggetto-causa e di oggetto-mira.
Per qualche spunto in più guarda questo video su emozioni e tempo vissuto:
L’Altro si configura allora come fonte esterna che sollecita il mio movimento emotivo (causa) e al contempo come destinatario e interlocutore finale del mio rivolgermi all’esterno (mira).
Non tutti gli stati emotivi sono destinati a seguire la trasformazione e il passaggio da umori ad affetti.
C’è una condizione dell’umore che è senza interlocutore e che costituisce la base temperamentale e caratteriale del soggetto.
Da un punto di vista psicopatologico la clinica dei disturbi dell’umore riguarda i disturbi d’ansia e i disturbi maniaco-depressivi. Per la comprensione fenomenologico-dinamica della questione soggettiva che soggiace a tali problematiche occorre tener presente l’oggetto e il senso dell’investimento intenzionale.
La coreografia che vede alternarsi emozioni come ansia, paura e angoscia può essere compresa riportando le variazioni del tono dell’umore alla cornice relazionale che fa da sfondo al progetto esistentivo del soggetto.
Risulta cruciale poter individuare se è presente o no un oggetto intenzionale che calamita i movimenti emotivi del soggetto, o se invece tali movimenti sono sganciati da un riferimento e da un ancoraggio relazionale.
La conduzione della cura non può prescindere dalla diagnosi differenziale tra emozioni legate all’Altro ed emozioni sganciate dall’Altro.
Il percorso terapeutico deve innanzitutto preoccuparsi di ridefinire i presupposti per un nuovo annodamento tra dimensione emotiva e relazione intersoggettiva.
Il compito della terapia consiste quindi nel favorire in primo luogo un’articolazione possibile tra soggetto e Altro, tra ciò che il soggetto prova e sente nascere nel proprio corpo e ciò che proviene come sollecitazione dall’Altro.
Una volta avvenuto questo primo collegamento, occorre stimolare il lavoro di elaborazione del soggetto riguardo alla effettiva posizione che occupa nei confronti del proprio oggetto intenzionale: si tratta di un’occasione per scoprire e definire il proprio stile interrogando la propria base umorale e la presenza affettiva dell’Altro.
Per qualche spunto in più guarda questo video sulla dipendenza affettiva.
Per approfondimenti, tra i libri di Nicolò Terminio, si rimanda a: